E. Morin. La testa ben fatta. Cortina, Milano, 2000.
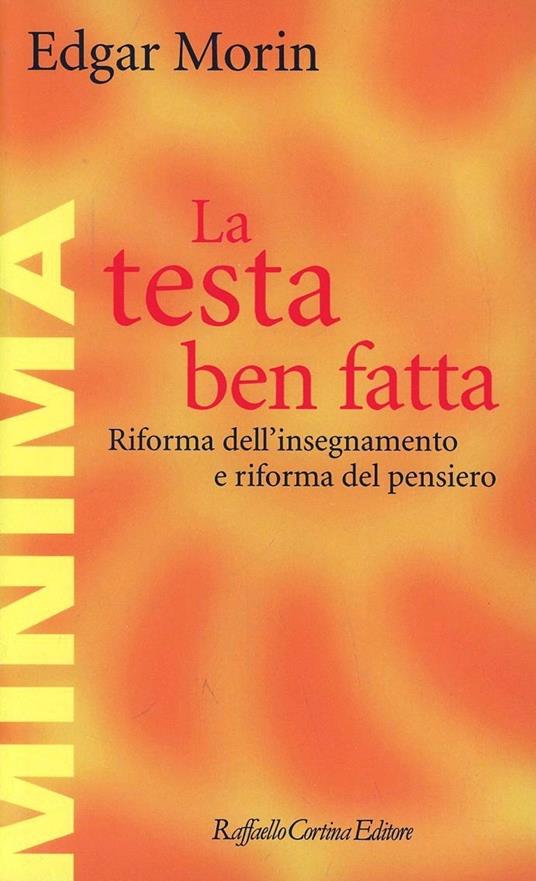
Prologo
L'educazione è un processo interattivo in cui si impegnano dei mezzi atti a promuovere la formazione e lo sviluppo di un essere umano. La formazione, con la sua connotazione di lavorazione e conformazione rischia di dimenticare l'importanza dell'autoapprendimento. L'insegnamento come arte di trasmettere conoscenza rischia di ridursi alla componente cognitiva. Si tratta di trasmettere non una quantità sempre maggiore di saperi, ma una cultura che permetta di comprendere la nostra condizione e ci aiuti a vivere. L'educazione può aiutare a diventare migliori e, se non più felici, ci insegna ad accettare la parte prosaica della nostra vita e a vivere con pienezza la parte poetica. Si tratta di costituire uno stato interiore profondo, una sorta di polarità dell'anima che ci orienti in un senso definito, per tutta la vita.
Cap 1) Le sfide.
L'approccio riduzionistico più che una soluzione dei problemi attuali è la loro stessa origine. Un'intelligenza incapace di considerare il contesto e il complesso planetario rende ciechi e irresponsabili. La conoscenza è tale solo in quanto mette in relazione e in contesto le informazioni. Essa progredisce principalmente con la capacità di contestualizzare. Le conoscenze frammentate servono solo per utilizzazioni tecniche. La saggezza integra le conoscenze per indirizzare la nostra vita verso scopi scelti dall'intelligenza (intesa secondo la definizione di Gadamer). La sfida culturale da affrontare è il superamento della disgiunzione tra cultura umanistica e cultura scientifica. La sfida civica riguarda l'indebolimento di una percezione globale che conduce all'indebolimento del senso di responsabilità (ciascuno tende ad essere responsabile solo del proprio compito specializzato) e della solidarietà (si percepisce solo il legame organico con il proprio gruppo di appartenenza..). Lo spossessamento del sapere da parte del cittadino pone il problema storico capitale della necessità di una democrazia cognitiva resa difficile dal sapere compartimentato ed esoterico. Ci vorrebbe una riforma di paradigma del pensiero, concernente la nostra attitudine a organizzare la conoscenza.
cap 2) La testa ben fatta.
La filosofia va intesa come una forza (originata dalla curiosità e dall'amore) di riflessione e di interrogazione sui problemi della conoscenza scientifica e non scientifica, sulla condizione umana e sulle grandi questioni della vita. Dovrebbe stimolare la razionalità critica e autocritica e la "fede incerta”. Ogni conoscenza è una traduzione e, nello stesso tempo, una ricostruzione (a partenza da segnali, segni, simboli) sotto forma di rappresentazioni, idee, teorie, discorsi. L'organizzazione della conoscenza comporta operazioni di interconnessione e di separazione : separazione-collegamento; analisi-sintesi; conoscere il tutto per conoscere le parti - conoscere le parti per conoscere il tutto (Pascal). L'essere umano è ancora vittima della disgiunzione natura-cultura, animalità-umanità, lacerato tra la sua natura di essere vivente studiata in biologia e la sua natura psichica e sociale, studiata nelle scienze umane. La cultura umanistica favorisce l'attitudine ad aprirsi a tutti i grandi problemi, l'attitudine a riflettere, a cogliere le complessità umane, a meditare sul sapere e a integrarlo nella propria vita per meglio chiarire correlativamente la condotta e la conoscenza di sé.
cap 3) La condizione umana.
Lo studio della condizione umana è illuminato, oltre che dalle scienze naturali (riaggregate), dalle scienze umane, dalla riflessione filosofica, dalla letteratura e dall'arte. Come nel cosmo la terra è estremamente marginale, così noi uomini siamo estremamente marginali nella vita terrestre, un ramo di un ramo di questa evoluzione. Portiamo all'interno di noi stessi il mondo fisico, quello chimico e il mondo vivente. La terra è una totalità complessa fisica-biologica-antropologica nella quale la vita è un'emergenza della storia terrestre. Come un punto di un ologramma noi portiamo in seno alla nostra singolarità non solo tutta l'umanità, tutta la vita, ma anche quasi tutto il cosmo. Occorre riconoscere ciò che può distinguere alla luce di ciò che unisce, affinché non separi. E riconoscere ciò che può unire alla luce di ciò che distingue, affinché non annulli gli apporti individuali. La poesia ci svela che abitiamo la terra non solo prosaicamente, sottomessi all'utilità e alla funzionalità, ma anche poeticamente, votati allo stupore, all'ammirazione, all'amore e all'estasi. Le arti ci schiudono la dimensione estetica dell'esistenza, ci insegnano a meglio vedere esteticamente il mondo. Ogni grande opera della letteratura, del cinema, della poesia, della musica, della pittura, della scultura svela un pensiero profondo sulla condizione umana. La filosofia, se si riavvicina alla sua vocazione riflessiva su tutti gli aspetti del sapere e della conoscenza dovrebbe far convergere la pluralità dei loro punti di vista sulla condizione umana. Si potrebbe, allora, giungere alla presa di coscienza della comunità di destino propria della nostra condizione planetaria, in cui tutti gli umani sono messi a confronto con gli stessi problemi vitali e mortali.
Cap 8' La riforma di pensiero.
Cartesio era molto meno cartesiano di quel che si vuol far credere. Il suo pensiero non è riducibile ai 4 principi del discorso sul metodo: 1) non accogliere come vero ciò che non conosci essere tale per certo; 2) suddividi ciascuna difficoltà in tutte le parti in cui è possibile e necessario dividerla per risolverla; 3) procedi con ordine, a incominciare dagli oggetti più semplici e facili, per salire progressivamente fino alla conoscenza dei più complessi; 4) fai ovunque enumerazioni così complete e rassegne così generali da essere certo di non aver tralasciato nulla. Il secondo principio porta con sé anche il principio di separazione e il terzo quello di riduzione. Ci si dimentica che per conoscere una parte occorre conoscere il tutto e che per conoscere il tutto occorre conoscere le sue parti, così come sostiene Pascal. Inoltre, sempre secondo il riduzionismo, il conoscibile è limitato al quantificabile, al misurabile, secondo l'assioma di Galileo. Ma né l'essere, né l'esistenza, né il soggetto conoscente possono essere matematizzati o misurati. Secondo Heidegger "l'essenza divoratrice del calcolo frantuma gli esseri umani, le qualità e la complessità, mentre porta alla quantofrenia. Ma 2 rivoluzioni scientifiche del XX secolo preparano alla riforma del pensiero. 1) La prima è incominciata nella fisica quantistica e ha infranto il principio deterministico, introducendo l'incertezza nella conoscenza scientifica. 2) la seconda rivoluzione si è realizzata con l'introduzione di grandi accorpamenti nelle discipline scientifiche (cosmologia, ecologia, geografia), sebbene resti ancora incompiuta, ad esempio, nelle scienze della vita, nelle scienze umane e sociali. Si sono, però, già formati saperi che consentono l'intelligibilità del complesso, a partire dalla cibernetica, dalla teoria dei sistemi, dalla teoria dell'informazione. Ci sono, poi, stati i contributi di pensatori scienziati che hanno riflettuto sulla conoscenza offerta dalle scienze (es. Jacob, Monod, Atlan..). E già nel XIX secolo la letteratura esplorava, con Balzac, Dostoevsky e Proust, la complessità umana. Tutti i capolavori della letteratura sono stati capolavori di complessità umana, ad esempio: - la rivelazione della condizione umana nella singolarità di un individuo (Montaigne); - la contaminazione del reale con l'immaginazione (il Don Chisciotte di Cervantes), il gioco delle passioni umane (Shakespeare). La letteratura rivela anche il valore cognitivo della metafora, che è un po' un ponte gettato dal campo del sensibile a quello delle emozioni. Il pensiero riformato sarà, quindi, un pensiero del contesto e del complesso, che collega e affronta l'incertezza, che mitigherà la rigidità della logica classica con una dialogica capace di concepire nozioni allo stesso tempo complementari e antagonistiche. Esso unirà, per tutti i fenomeni umani, la spiegazione alla comprensione. Spiegare è considerare il destinatario del proprio interesse soltanto come un oggetto, di cui si devono determinare le forme, le qualità e le quantità e di cui si conosce il comportamento per causalità meccanica e deterministica. La spiegazione è necessaria alla comprensione intellettuale ed obbiettiva. Ma è insufficiente per la comprensione umana. C'è una conoscenza comprensiva che si fonda sulla comunicazione, sull'empatia. Comprendere comporta un processo di immedesimazione e di proiezione da soggetto a soggetto, richiede apertura, generosità, benevolenza (come sostiene Panikkar). Ci sono 7 principi guida per un pensiero riformato di questo tipo: 1) il principio sistemico: un sistema è qualcosa di più e comunque di diverso dalla somma delle sue parti. NDR Le proprietà emergenti nascono dalle interazioni; 2) il principio ologrammatico per cui ciascuna parte ha gli elementi costitutivi del tutto (ad es. ogni cellula ha il DNA costitutivo dell'intero organismo); 3) principio dell'anello retroattivo, che è regolativo nel senso della stabilizzazione (riparativo delle devianze) o della amplificazione (inflazionistico...) o della attenuazione. 4) principio dell'anello ricorsivo che supera il momento della regolazione (la società produce l'individuo il quale produce la società...) 5) il principio dialogico che contempera insieme complementarietà ed antagonismo... 6) il principio dell'autonomia/dipendenza il soggetto assorbe energia, informazioni dall'ambiente circostante (vedi dipendenza--->autonomia---->interdipendenza); 7) il principio dell'integrazione del soggetto conoscente in ogni processo di conoscenza... dell'inclusione del soggetto conoscente nell'oggetto conosciuto ... La riforma non è programmatica, ma paradigmatica, poiché concerne la nostra attitudine a organizzare la conoscenza. La nostra lucidità dipende dalla complessità del modo di organizzare le nostre idee (vedi mappe cognitive). La riforma può portare a un nuovo umanesimo che tenga conto non solo dell'eredità greca (la sovranità dei cittadini sulle loro città e della ragione sul pensiero) dell'eredità giudaico-cristiana (l'uomo a immagine di Dio, Dio che prende sembianze e carne umane), ma anche di 4 scoperte scientifiche fondamentali: 1) la rivoluzione copernicana che infrange il geocentrismo; 2) quella di Darwin che infrange un antropocentrismo ingenuo; 3) quella di Freud che desacralizza lo spirito umano; 4) e infine quella di Hubble che ci esilia in una delle periferie più lontane del cosmo (vedi anche Ceruti). Questo nuovo umanesimo non dovrebbe più essere portavoce dell'orgogliosa volontà di dominare l'universo, ma della solidarietà tra gli esseri umani, il che implica una relazione ombelicale con la natura e con il cosmo. Quindi la riforma del pensiero è capace di prolungarsi in un'etica di interconnessione, di solidarietà, di corresponsabilizzazione con conseguenze esistenziali, etiche, politiche.
Cap 9) Al di là delle contraddizioni.
Non si può riformare la scuola o le istituzioni senza prima aver riformato le menti.; ma non si possono riformare le menti senza prima aver riformato le istituzioni (ricorsività). Le menti sono formate, per lo più, tramite il modello della specializzazione chiusa. La possibilità di una conoscenza che esorbiti da questa specializzazione sembra insensata. Gli specialisti, tuttavia, possiedono idee generali sulla vita, sul mondo, la natura, Dio, gli uomini, le donne, ma arbitrarie, mai criticate e mai riflettute. E sono queste idee che fanno da sfondo al loro agire, nei loro stessi campi specialistici, con conseguenze potenzialmente devastanti. La relazione tra scuola e società è anche ologrammatica nel senso che come un ologramma porta in ogni punto la totalità della figura che rappresenta, anche la scuola, nella sua singolarità, porta in sé la presenza dell'intera società. NB Bisogna saper cominciare, e l'inizio non può che essere deviante e marginale. L'università moderna, che ha rotto con quella medievale, è nata all'inizio dell'800 a Berlino. L'insegnamento non è solo una funzione: renderebbe l'insegnante un semplice impiegato; non è una professione: lo renderebbe un esperto; è una missione che presuppone arte e tecnica e benevolenza, piacere per il dono. Se non c’è amore ci sono solo problemi di retribuzione, di carriera e di noia. All'origine della laicità nata nel Rinascimento sta la problematizzazione sul mondo, la natura, la vita, l'uomo, Dio. All'inizio del 900 si credeva che il progresso, la scienza, la tecnica, la ragione avrebbero portato le soluzioni a tutti questi interrogativi. Ma oggi si devono problematizzare anche il progresso, la scienza, la tecnica, la ragione. Si deve problematizzare la scienza svelandone le profonde ambivalenze; la ragione, opponendo alla razionalità aperta quella chiusa; il progresso che dipende non da una necessità storica, ma da una volontà cosciente degli umani. Occorre un nuovo Rinascimento, occorre frenare il deperimento democratico suscitato in tutti i campi della politica dall'espansione esorbitante dell'autorità degli esperti, degli specialisti di tutti i tipi che limitano progressivamente la competenza dei cittadini. Lo sviluppo di una democrazia si basa, oggi, sullo sviluppo di una democrazia cognitiva che è possibile all'interno di una riorganizzazione del sapere. Bisogna distinguere senza separare, e interconnettere per far rinascere in modo nuovo le nozioni frantumate dal frazionamento disciplinare: l'uomo, la natura, il cosmo, la realtà. Oggi siamo vittime di 2 tipi di pensiero chiuso:
1) il pensiero parcellizzato della tecno-scienza;
2) il pensiero ripiegato sull'etnia o la nazione che fraziona in puzzle il tessuto della Terra-patria.