Ferrarese Es. Il mercato della virtù. Lit edizioni, Roma 2024.
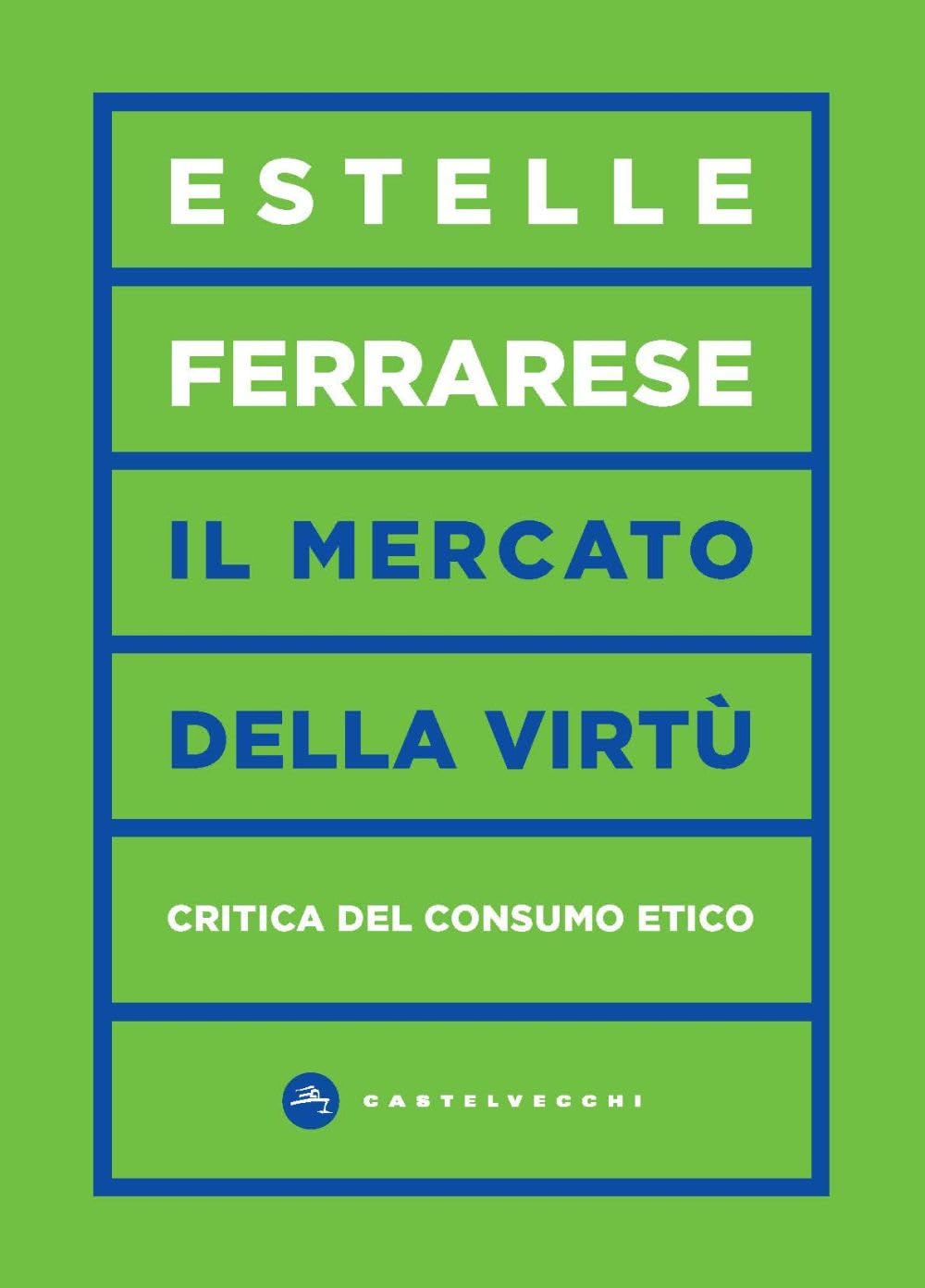
Riassunto parziale
Introduzione
Il consumo critico o etico o l’acquisto responsabile è quello che sceglie di acquistare quei prodotti che, nel ciclo della loro produzione, hanno rispettato gli esseri umani e la natura. Sono pratiche che appartengono all’economia solidale o all’economia sociale, che assegnano alla produzione l’obbiettivo della giustizia sociale e del rispetto dell’ambiente (in conformità col dettato dell’art. 41 della Costituzione). A volte si perseguono obbiettivi conflittuali come la prossimità tra produttore e acquirente e, nel contempo, gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo; o la tutela dell’ambiente e la protezione del mercato del lavoro. Il segno distintivo del consumo etico è la preoccupazione per gli altri nel contesto delle transazioni. Il nemico non è tanto il mercato in sé, con le sue leggi e i suoi automatismi, quanto l’indifferenza e la freddezza dei suoi attori. Oggi il consumo etico si basa sulla minaccia di una catastrofe ambientale: consumare eticamente o morire. Polany sviluppa una teoria della crisi del capitalismo come effetto non tanto di un collasso economico quanto della disintegrazione della comunità, della rottura della solidarietà e dello sfruttamento della natura. Lo Stato, la legislazione e varie istituzioni pubbliche sono state mobilitate per cercare di salvaguardarci dagli effetti di questa crisi e dagli aspetti più predatori del capitalismo. Si è chiarito, ad esempio, che il mercato non può funzionare appropriatamente se le persone non si sono previamente riconosciute moralmente come membri di una comunità cooperante in cui ognuno percepisce nella realizzazione della libertà dei suoi simili la precondizione per la realizzazione della propria libertà. Il consumo etico rappresenta anche una riflessione sulla vita buona, sulla natura e sugli esseri umani, sulla responsabilità e la vita morale. Secondo Habermas, tuttavia, nella sua teoria dell’agire comunicativo, il mercato capitalistico è impermeabile a norme, disposizioni e argomentazioni morali perché trova la sua finalità in sé stesso, nell’accumulo di capitale e non in riferimento a un bene comune o a un interesse collettivo.
Capitolo 1
Il socialismo morale non è tanto orientato alla rivoluzione o alla collettivizzazione dei mezzi di produzione, ma alla trasformazione di un mercato capitalistico che è entrato in rotta di collisione con la libertà e l’eguaglianza. Nell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII alla fine dell’800, si sostiene che il libero consenso del lavoratore e del suo datore di lavoro non garantisce che il salario pattuito sia giusto. È troppo sbilanciato il potere contrattuale. Il salario giusto è quello che rispetta la dignità della persona umana e assicura al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza decente (art. 23 della dichiarazione universale…). Secondo Aristotele, nell’etica Nicomachea, il prezzo è giusto quando assicura l’eguaglianza dei vantaggi che ciascuno trae dallo scambio. Ma a essere giusta non è tanto la valutazione quanto ciò che costituisce il prerequisito della correttezza, ossia l’attenzione o la preoccupazione per altri, la cura della relazione. La monetizzazione della diversità biologica, uno strumento che aiuta le decisioni pubbliche, è un modo per attribuire un valore monetario agli ecosistemi a scopo euristico. Oltre alla sfera del conto “natura” c’è la sfera del conto “giustizia sociale” in cui riportare i costi della compromissione delle relazioni, della fiducia, della coesione e della solidarietà. Il prezzo del carbonio incorpora i costi dei danni causati dal riscaldamento globale (è considerato una esternalità). L’impronta ecologica è un indice artificiale di sostenibilità ecologica che fornisce informazioni sull’esaurimento delle risorse naturali. Ci ricorda che alcune azioni lasciano il segno e che è compito della scienza stabilire le condizioni e i limiti entro i quali lo sviluppo della sfera tecno-industriale può essere perseguito senza compromettere le capacità di auto-rigenerazione dell’atmosfera. Oggi la figura del lavoratore autonomo, che beneficia dello statuto di auto-imprenditore, aggiorna le forme di sfruttamento dissociandole dal lavoro dipendente. A questo proposito, va ricordato che non si deve solo evitare di trarre vantaggio dal proprio potere, ma va abolito il diritto o la possibilità di danneggiare e sfruttare gli altri.
Capitolo 2
Il consumo etico costituisce una critica del capitalismo, rivale rispetto alla critica marxista. Le cooperative di consumo dell’800 e del primo novecento vengono, infatti, accusate dai marxisti di perpetuare il lavoro salariato, a causa del quale i lavoratori non possono essere padroni di loro stessi. Il consumo etico, incarnato dalle cooperative di consumo, condanna la brama predatoria e il feticismo delle merci, che nasconde il fatto che il mercato è una relazione tra esseri umani e non tra oggetti. Tra esseri umani che hanno un volto e una biografia. Viceversa, nel feticismo, le merci sono intese come se fossero animate di vita propria lasciando sullo sfondo i volti degli attori del mercato. Il consumo etico è caratterizzato dalla misura, dalla preoccupazione per gli altri, per le future generazioni, per gli animali, le piante, la natura. Nella critica al capitalismo esso dà una netta priorità all’appropriazione delle risorse naturali, che finisce per trasformare, degradare il terreno e prosciugare le falde acquifere. L’appropriazione è vista come il fulcro del processo di accumulazione, anche al di sopra dello sfruttamento degli esseri umani. Il capitalismo è vittima periodica di una tendenza alla crisi provocata dalla contrazione della domanda e del consumo, insufficiente ad assorbire la crescita della produzione. Le crisi vengono, poi, contrastate da nuovi imperialismi e da nuove rivoluzioni scientifiche. Le cooperative di consumo rappresentano il luogo del progresso morale perché eliminano la ricerca del profitto e la sostituiscono con la preoccupazione di soddisfare i bisogni abolendo pubblicità e mistificazioni. Attraverso la cooperazione rendono lo scambio il regno della verità e della giustizia. Il capitalismo, invece, si basa sulla passione per accaparrare, divorare e distruggere. Il modo di produzione capitalista viene, così, ridefinito sulla base della psicologia degli individui anziché sulla base delle relazioni sociali che lo strutturano.
Conclusione
Il consumo etico fornisce un’interpretazione del capitalismo limitata a processi psicologici, a una brama predatoria e a una fascinazione esercitata dalle merci. Il consumo etico è una scommessa sulla trasformazione del mercato attraverso la misura. Ma, secondo l’autrice, la disponibilità di merci, anche se più etiche e di alternative più eco-responsabili portano, inevitabilmente, a infliggere nuovi danni alla Natura, al lavoro e alle relazioni sociali. Il consumo etico, nonostante le buone intenzioni, rende il singolo individuo responsabile di relazioni e condizioni di cui, invece, rimane il prodotto sociale. Se non c’è una vera libertà non può esserci nemmeno una vera responsabilità. In realtà il vocabolario della scelta non fa che dissimulare il fatto che, in un sistema di produzione capitalistica, non esiste scelta possibile.