Sandel M. La democrazia stanca. Ed. Feltrinelli, Milano 2024.
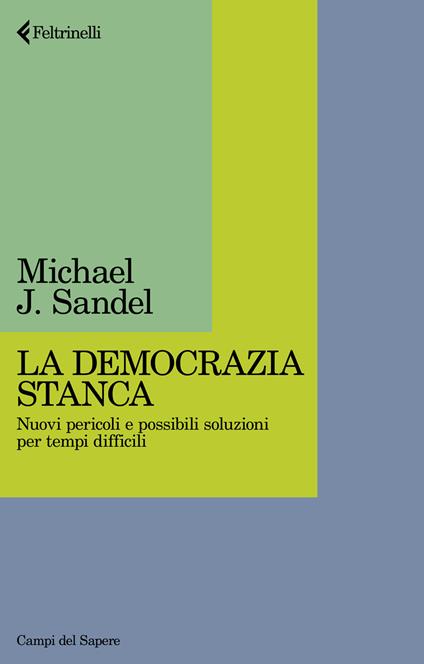
Riassunto parziale
Prefazione
Attenzione alla distanza tra principi e pratiche politiche. È difficile che le pratiche politiche possano funzionare se i principi filosofici su cui si basano sono sbagliati.
Introduzione alla nuova edizione
La globalizzazione, la finanziarizzazione dell’economia e dell’industria, la cultura meritocratica hanno avvantaggiato una stretta minoranza di vincitori. Ma i perdenti sono la maggioranza, e hanno visto la riduzione dei posti di lavoro e il blocco dei loro salari. Da 4 decenni si sono accresciute le disuguaglianze e si è fermato l’ascensore sociale in una misura mai vista dagli anni 20 del 900. Il governo guidato dal mercato ci ha fatto perdere il controllo sulle forze che governano la nostra vita. Si è affievolito il progetto di auto-governo. L’autogoverno richiede che le istituzioni politiche mantengano il potere economico in mani democratiche e una coesione tra i cittadini per impegnarsi in un progetto comune. Ma si sono affievoliti i legami tra i cittadini. Occorre dare ai cittadini la possibilità di pensare a sé stessi come partecipanti a una vita pubblica condivisa. I nostri dibattiti politici riguardano soprattutto la crescita economica e la giustizia distributiva. Ma questo è un modo troppo riduttivo di pensare all’economia. Dobbiamo anche creare un’economia ospitale per il progetto di autogoverno, dove tutti possano guadagnarsi da vivere decentemente, abbiano voce e siano preparati a deliberare sul bene comune. Ma su quali siano gli assetti economici più adatti all’autogoverno esistono differenti opinioni.
Capitolo 1
Le nostre democrazie segnalano un certo scontento dovuto, da una parte, alla sensazione di avere perso il controllo sulle forze che governano la nostra vita e, dall’altra, alla percezione che il tessuto morale che tiene insieme la nostra comunità si stia sfilacciando. L’incapacità della politica americana a sedare queste preoccupazioni ha a che fare con la filosofia pubblica che fa da cornice alle nostre vite. Il liberalismo non aspira a convalidare alcuna visione particolare della vita buona. Ogni persona è libera di scegliere da sé i valori e i fini che devono improntare la propria vita, una volta che siano garantiti il rispetto dei diritti degli altri e la tolleranza. Ci si ispira a pensatori come John Locke, Immanuel Kant, John Stuart Mill, John Rawls. La priorità viene assegnata a procedure eque piuttosto che a fini appropriati. A differenza dal liberalismo la teoria repubblicana assume che la libertà dipende dalla partecipazione all’autogoverno e richiede un senso di appartenenza, una sollecitudine verso l’interesse generale e un legame morale con la comunità. Non si può essere, quindi, neutrali rispetto ai valori e ai fini cui aderiscono i cittadini. E’ necessaria, perciò, una politica formativa. Il contrasto tra il liberalismo e la teoria repubblicana mette in luce 2 modi diversi di pensare l’economia. Per la concezione liberale il consumo è l’unico scopo dell’economia. Per la concezione repubblicana l’economia non serve solo al consumo, ma anche all’autogoverno. Dovrebbe prepararci a essere cittadini, non solo consumatori. L’organizzazione della produzione e degli investimenti condiziona la possibilità, per i cittadini, di avere voce in capitolo in ambito politico e nel modo in cui assegniamo riconoscimento e stima sociale. Anziché ignorarle, il nostro discorso politico dovrebbe accogliere le convinzioni morali e religiose che le persone portano nella sfera pubblica. La filosofia pubblica con cui conviviamo non è in grado di garantire le libertà che promette perché non può ispirare il senso di comunità e di impegno civico che la libertà richiede.
.....................................................................................
Conclusione
Viviamo in società frammentate, pluri-valoriali, pluri-etniche e pluri-religiose. È difficile trovare degli scopi comuni che ne consolidino la coesione. Meglio, quindi, la tolleranza e accontentarsi delle scelte individuali? Ma i buoni cittadini non vanno tanto trovati, vanno formati. Occorre fare attenzione, però, perché accordare alla comunità questo ruolo nella formazione dei cittadini implica la possibilità che cattive comunità possano formare cattivi caratteri. Alcuni sostengono che si deve distinguere tra vita privata e vita pubblica. Solo nella vita privata ci si deve attenere a obbligazioni particolari di carattere morale che potrebbero confliggere con quelle di altri concittadini. Nella vita pubblica, invece, occorre la neutralità rispetto a principi e valori. Ma l’incapacità di autogoverno, legata alla difficoltà di accordarci su scopi condivisi, ci fa confrontare con un mondo governato da strutture di potere impersonali che vanno al di là della nostra comprensione e del nostro controllo. Anche per questo siamo sprofondati in disuguaglianze abissali che non si vedevano dagli anni 20 del 900. Al di là della questione della distribuzione del denaro, le nuove disuguaglianze pongono il problema della separazione dei cittadini in enclave omogenee e del ritiro dalla vita pubblica di masse di cittadini sfiduciati. Le scuole pubbliche, oltre che essere un luogo di socializzazione, dovrebbero essere un posto dove si apprendono le abitudini della cittadinanza democratica. I problemi più gravi che ci affliggono sono globali, ma il potere degli stati-nazione è locale. Come progettare istituzioni politiche in grado di governare l’economia globale? Come coltivare le virtù civiche necessarie per sostenere tali istituzioni e fornire loro l’autorità morale necessaria? Persino l’Unione europea, uno degli esperimenti meglio riusciti di governo sovranazionale, ha fallito nel coltivare una identità europea condivisa. L’esito è stato quello di un’Europa degli uomini d’affari, non dei cittadini. Si potrebbe intravedere nei movimenti per l’ambiente, i diritti umani, la pace, le donne, l’emergere di una società civile globale. L’amore per l’umanità è certo un sentimento nobile, ma impariamo ad amare l’umanità non in senso astratto e generale, bensì attraverso espressioni di solidarietà più vicina. La sovranità nazionale è erosa in una duplice direzione: dall’alto dal potere delle multinazionali e, dal basso, da aspirazioni di autonomia di gruppi sub-nazionali. Nonostante ciò, lo stato nazione non deve necessariamente scomparire, ma deve rinunciare all’idea di essere l’unico depositario del potere sovrano. L’alternativa non è un’unica comunità mondiale basata sulla solidarietà, ma una molteplicità di comunità e corpi politici tra i quali la sovranità è diffusa. Il federalismo è più di una teoria delle relazioni inter-governative. Suggerisce che l’autogoverno funziona meglio quando la sovranità è distribuita e la cittadinanza si forma attraverso molteplici luoghi di impegno civico, dai quartieri alle città, alle nazioni e al mondo. Attenzione, però, al rischio del fondamentalismo che vorrebbe bandire qualsiasi ambiguità e irrigidire le distinzioni. E, per contrasto, attenzione anche alle identità mutevoli, senza storia. I legami della comunità politica dipendono, infatti, dalle narrazioni attraverso cui le persone danno un senso alla loro condizione e interpretano la vita comune che condividono.
Epilogo
Capitalismo e democrazia hanno manifestato una convivenza difficile. Il capitalismo ha cercato di organizzare la produzione in funzione del profitto privato. La democrazia cerca di conferire potere ai cittadini in funzione dell’auto-governo. L’economi politica della cittadinanza ha rappresentato il tentativo di conciliare questi 2 progetti. Dopo la seconda guerra mondiale l’economia politica della cittadinanza è stata soppiantata dall’economia politica della crescita economica. L’economia veniva, così, concepita in termini consumistici per cui la libertà individuale consiste nel perseguire i propri fini egoistici, non nel condividere l’auto-governo e nell’aver voce in capitolo. Nel primo ventennio di questo secolo il malcontento si è acuito e la coesione sociale si è ulteriormente allentata. La versione attuale del capitalismo, abbracciata da entrambi i partiti, punta, infatti, su globalizzazione, finanziarizzazione e meritocrazia. Gli investimenti contano meno, l’ingegneria finanziaria conta di più. Il carico fiscale si è spostato dalle società per azioni ai lavoratori e ai consumatori. Obama nel 2008 ha preferito salvare i banchieri di Wall Street e ha lasciato che 10 milioni di proprietari di case perdessero la loro abitazione a seguito dei pignoramenti. La crescente disuguaglianza ha corrotto la democrazia in 2 modi: promuovendo una progressiva concentrazione di ricchezza e potere e diffondendo la cultura meritocratica: un modo di pensare al successo umiliante per i tanti perdenti. Così come i vincitori meritano le fortune che il mercato concede loro, anche i perdenti meritano il loro destino. I perdenti non sono rappresentati. Più della metà dei membri del congresso sono milionari. La pandemia da Covid 19 che ha provocato più di 6 milioni di morti nel mondo ha falsificato l’ipotesi che i meccanismi di mercato possano definire e realizzare il bene pubblico. Tanto è vero che ci sono stati imponenti interventi dei diversi Stati anche a livello sovranazionale, in accordo con le tesi keinesiane. Certo, non è facile trovare un accordo su ciò che vogliamo fare riconsiderando i nostri modi di convivere con gli altri e con la natura, le virtù che ci rendono pienamente umani. Ma nelle società pluralistiche le persone non sono d’accordo sulla vita buona. Meglio, allora, essere neutrali, aderire all’economia politica della crescita e piegare il liberalismo verso la fede nel mercato? I mercati sono una fonte di accordo con consenso unanime. La loro attrattiva più forte non consiste nel procurare efficienza e prosperità, ma nel risparmiarci la necessità di dibattiti estenuanti, intricati e conflittuali su come valutare i beni. Si tratta, però, di una falsa promessa. Bandire le questioni eticamente controverse dal dibattito pubblico non porta a sospendere le decisioni su di esse, ma significa semplicemente che i mercati, diretti dai ricchi e dai potenti decideranno tali questioni per noi. L’aspirazione civica a plasmare le forze che governano le nostre vite ci chiede ora di ragionare su principi, valori e finalità per ridare un senso all’impegno e alle nostre vite.